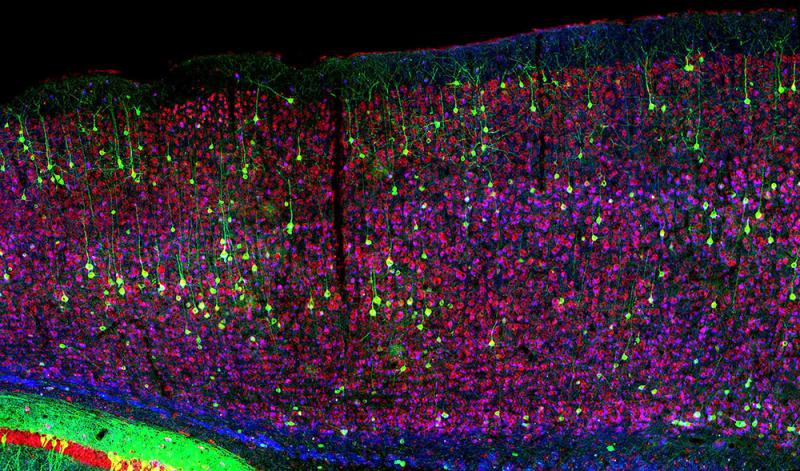Desiderio digitale
A chi appartiene il nostro inconscio?
Se mai tornerò da una terapista, le porterò gli screen dei Tik Tok che faccio quando sono in stati onirici e le dirò: ecco, questo è il mio inconscio.
M., conversazione su Telegram.
La relazione che lega “biologia” e tecnologia di norma viene inquadrata in una cornice teorica in cui si riverberano molte aporie derivanti dalla dicotomia concettuale mente/corpo. Le speculazioni su innesti artificiali, realtà virtuale o altre forme di percezione aumentata tendono, da una parte, a considerare queste “protesi” sensoriali come semplici estensioni dell’Io, che nella sua totalità resterebbe inalterato; dall’altra avviene invece una sorta di psicologizzazione dell’esistenza virtuale secondo cui quest’ultima non sarebbe che uno “specchio” dell’esistenza psichica offline.
In quest’ottica una sempre più lunga lista di “disfunzionalità” psichico-cognitive deriverebbe da una sorta di effetto “amplificatorio” dei nuovi media, che, di conseguenza, vengono o esclusi dall’equazione o codificati secondo categorie cliniche che sembrano ora più che mai in piena obsolescenza. Generalmente, per esempio, ci si riferisce a certi fenomeni propri della dimensione dei social come manifestazioni narcisistiche: la costante esposizione e promozione della propria immagine, in selfies, vlogs e narrazioni ossessivamente auto-riferite sarebbero la dimostrazione di un “patologico” (?) ripiegamento sull’Io.
Tuttavia, già ben prima della fioritura di Facebook, Instagram e Tik Tok, sia McLuhan sia Baudrillard teorizzavano alcune differenze fondamentali fra la concezione “classica” del narcisismo e le nuove sfumature conferitegli dall’ecosistema digitale. Secondo McLuhan, per esempio, esiste una continuità fra il nostro sistema nervoso e l’ecosistema tecnologico, che viene confuso per qualcosa di esterno solo per la nostra incapacità di elaborare l’immensa quantità di stimoli che questo produce. Il Narciso moderno dunque, più che un atto di riflessione, consisterebbe in una sorta di auto-amputazione in cui una parte dell’Io viene ceduta a una (supposta) esteriorità sotto l’incessante pressione della stimolazione digitale. Per Baudrillard, al contrario, non si tratta di frammentazione, piuttosto di integrazione. L’Io, nel narcisismo digitale, è collassato sulla sua stessa immagine – è l’incapacità radicale del soggetto di distaccarsi dal circuito in cui è inserito.
Molte delle formulazioni teoriche circa i nuovi media, bisogna ammetterlo, sono spesso gravate da un’eccessiva astrattezza, che a volte sconfina nella speculazione fantascientifica. Tuttavia, indipendentemente dal loro valore di verità, sono sintomatiche dell’inadeguatezza di una certa tradizione psicanalitica nell’analisi della nostra dimensione psichica digitale (da cui la costante necessità di upgradare concetti psicoanalitici classici, senza però mai metterne in discussione gli assunti fondanti), e di una esponenziale impossibilità nella differenziazione fra esistenza offline e online, o fra esistenza “biologica” e tecnologicamente mediata. E, cosa ancora più importante, tracciano un percorso che permette di estendere questa generale indistinzione anche alla presunta membrana che separa reazioni psicologiche e fisiologiche. Senza scomodare – per ora – intricate architetture teoretiche, già nell’esempio dell’identificazione-rappresentazione mediale dell’Io nei social è evidente come la sempre maggiore sofisticazione della propria immagine non abbia ripercussioni solo sui meccanismi di identificazione, ma come crei un’integrazione di valori digitali nel proprio Io e comporti inevitabilmente anche una serie di conseguenze fisiologiche: disturbi alimentari, esercizio ossessivo, compulsioni gestuali-facciali, e un sempre più frequente ricorso alla chirurgia plastica, nell’impossibile anelito a rispecchiarsi in un ideale dell’Io forgiato in un diverso piano di realtà.
Un filone di teoria e critica dei media in particolare cerca di bypassare le aporie dualistiche e articolare più dettagliatamente la complessa rete di retroazioni bio-tecnologiche servendosi della nozione spinoziana di affetto – ossia, “la capacità di agire ed essere agiti”; la condizione di “intermedietà” in cui “le intensità passano da corpo a corpo” e “risuonano” fra corpo e mondo, indicizzando “gli stessi passaggi e le stesse risonanze” (M. Gregg, The Affect Theory Reader). O, in un registro più prosaico, azioni e reazioni psico-somatiche preconsce che innescano, in virtù della loro intermedietà, metamorfosi cognitivo-mentali e fisiche. L’esposizione ai media, e le varie forme di interfaccia bio-tecnica non sono dunque semplici estensioni dell’Io o epifenomeni che ne lascerebbero inalterate le condizioni di esistenza ed espressione, ma ben più complessi concatenamenti che mettono in discussione le cristallizzate concezioni dell’identità e del corpo, e, ancora più in profondità, evidenziano come queste siano sempre state, in definitiva, plasmate dall’ecosistema mediale in cui sono nate.
È proprio il ricorso alla nozione di affetto che serve, in ultima istanza, a colmare le lacune teoretiche che riguardano in particolare l’articolazione psichica e desiderante del (s)oggetto moderno, sulla scia delle prescienti constatazioni di Frederic Jameson e Robert Lasch circa la fine dell’Io borghese o dell’“Io imperiale” (l’Io su cui è fondata la teoria psicoanalitica) e di conseguenza la “fine delle patologie di quell’Io”. Come sostiene Mark Fisher nella sua tesi di dottorato, Flatline Constructs, “l’equazione freudiana fra occhio e pene [visione e libido] non ha più alcuna rilevanza in condizioni in cui non esiste distanza […] non puoi toccare senza essere toccato. Non puoi penetrare ciò che ti avvolge”. E, anche senza che la realtà virtuale abbia raggiunto il pieno sviluppo, ci ritroviamo già perfettamente immersi nell’ecosistema mediatico – la stessa emersione della categoria del prosumer sancisce l’impossibilità di esistere in un distacco contemplativo rispetto alla produzione e alla circolazione delle rappresentazioni digitali.
Luciana Parisi e Tiziana Terranova nel loro A Matter of Affect: Digital Images and the Cybernetic Re-Wiring of Vision analizzano precisamente questi due elementi: l’immersività tecnologica e la conseguente pervasività affettiva dei media, che consolidano una relazione di continuità fra io e non-io rendendone i confini sempre più sfumati.
La cultura dei media digitali mette in discussione il distacco necessario a esercitare lo sguardo sadistico, classificatore. [Gli] effetti digitali sopraffanno lo spettatore con una richiesta di partecipazione che non implica tanto il controllo, quanto l’immersione in un flusso di immagini liquide. Lungi dal determinare una relazione fra interno ed esterno, soggetto e oggetto, gli effetti digitali incrinano la membrana che separa il corpo e l’immagine.
E concludono, citando David Cronenberg:
Più le immagini divengono indipendenti e distanti dalla loro fonte rappresentazionale più si iscrivono in profondità nei nostri nervi e nelle nostre sinapsi.

La cultura visuale in ogni caso non rappresenta una dimensione isolata del digitorama contemporaneo, anzi, le immagini che quotidianamente produciamo e consumiamo, sono, come sostiene Steve Anderson in Technologies of Vision nulla più che manifestazioni “superficiali” di un intricato sistema di relazioni e retroazioni coestensivo alla progressiva datificazione del reale - una sorta di epifenomeno estetico del dedalo di dati, codici e algoritmi. Questa concezione dell’immagine si sovrappone perfettamente alle teorie di Burroughs – autore di riferimento di molta speculazione cibernetica: secondo Burroughs le immagini sono essenzialmente una stimolazione neuronale, capace di condensare infinite associazioni. In questo modo qualsiasi immagine può operare come catalizzatore del desiderio, che, a differenza della concezione “istintiva” freudiana, opera come una circuiteria ricodificabile di stimolazioni e risposte. Il desiderio viene dunque effuso nella tecnologia che conserva e ripete associazioni e compulsioni per offrirle di nuovo al recettore biologico, modificandone l’operatività affettiva secondo i propri criteri. Così, le immagini che incanalano la nostra attenzione testimoniano una più profonda e complessa ricalibratura dell’apparato psichico: non siamo attratti, eccitati, dalla figura che quell’immagine “rappresenta” ma dalla stessa tessitura dell’immagine, dalla quantità di pixel, dalla sequenza di bit, dalle oscure dinamiche algoritmiche che l’hanno fatta apparire lì, esattamente in quel momento. Ci affascina in processo di ricerca stesso in una Sehnsucht dispiegata dalla prospettiva di un dettaglio sempre più perfetto, sempre più insignificante. Come nota – nonostante un evidente essenzialismo – Carmelo Buscema ne L’epocalisse finanziaria:
[L]a riproduzione digitale della realtà avviene a un livello che si colloca ben oltre la normale capacità di percezione della sensorialità umana: quest’ultima, quindi, risulta potenziata dall’uso dei dispositivi digitali e dalla disponibilità diffusa dei suoi prodotti […]. Dunque, il mondo surrogato integra e arricchisce il mondo reale e autentico, del proprio portato di iper- e ultrarealtà informazionale.
E simultaneamente la realtà “rappresentata”
[arricchisce] le immagini dello specchio digitale di riverberi assoluti che non trovano più corrispondenza nella realtà riflessa.
E così, in una ciclicità che elide ogni mediazione, quando inseriamo la nostra stessa immagine nel circuito creiamo a nostra volta “doppi” digitali senza corrispondenza che incrinano i processi proiettivi e identificativi e sanciscono la nostra totale immersione nella rete.
La possibilità di modificare e rielaborare un’immagine fin nel minimo dettaglio non solo problematizza la natura stessa dell’oggetto che desideriamo, ma – ricordandoci che ogni oggetto è suscettibile di perfezionamento – innesca una ricerca impossibile e interminabile, proprio perché priva l’oggetto della sua presenza “fissa”, della sua attualità, in un’operazione perfettamente funzionale ai meccanismi del capitalismo digitale. In questa ricerca impossibile di oggetti o identificazioni sempre potenzialmente migliori, da una parte le dinamiche psichiche di proiezione e introiezione iniziano a interagire con una dimensione a-significante e a-soggettiva, dall’altra i meccanismi del desiderio iniziano ad articolarsi secondo criteri propri della circolazione digitale – secondo i modelli induttivi algoritmici. Parisi e Terranova evidenziano come le immagini digitali e la loro manipolazione mettano “in discussione la dinamica della rappresentazione fra sé e altro” e costituiscano una seria minaccia “alle concezioni dell’identità psichica di stampo lacaniano” (L. Parisi e T. Terranova, A Matter of Affect). Secondo queste concezioni uno degli elementi fondanti nell’articolazione del soggetto e del suo desiderio è il dominio dell’Altro, la dimensione Simbolica. Dimensione che è possibile ricondurre ai processi socioculturali dell’esistenza umana – processi che ora sono quasi completamente di pertinenza digitale. In questo dominio, come dimostrano molti testi seminali di teoria cibernetica, forma e contenuto collassano, lasciando come unico criterio di lettura una dimensione procedurale. Le funzioni del Simbolico sono diventate funzioni algoritmiche.
Ora, diventa lecito supporre che le sempre più diffuse disfunzionalità dell’Io indicizzate dalla psicanalisi siano in realtà ri-articolazioni di quell’Io attraverso un nuovo Altro – un Diverso – secondo i suoi criteri operativi immanenti. È via via più verosimile, dunque, che l’ecosistema mediatico stia digitalizzando il nostro desiderio.
La nebulosità di queste formulazioni teoretiche trova un sostegno empirico in una serie di ricerche incentrate su ciò che viene definito “desiderio del consumatore”. Nonostante l’enorme varietà di metodi e prospettive, ciò che emerge con una certa chiarezza è la stretta connessione fra le condizioni materiali di comunicazione di un’epoca e le modalità in cui queste incanalino il nostro desiderio secondo le loro logiche intrinseche. In Redistributed consumer desire in digital virtual worlds of consumption, uno studio del 2013, vengono esaminate proprio le specifiche condizioni d’espressione del desiderio negli “spazi virtuali” a gestione algoritmica. Il paper evidenzia come l’ecosistema digitale ponga gli oggetti di desiderio in una condizione liminale fra l’immaginazione del consumatore e un’effettiva materialità - condizione che si riverbera in una sorta di quasi-possesso nel caso in cui, nel corso dello shopping online, questi oggetti vengano inseriti nel carrello senza però essere acquistati. Secondo questo modello inoltre, sembra emergere una tendenza secondo cui il “desiderio di comprare qualcosa” non origina dall’idea precisa di un bene specifico, ma da una vaga immagine ascrivibile a un sistema di oggetti – in questo modo i suggerimenti di ricerca informatizzati si inseriscono alla fonte del desiderio del consumatore e ne influenzano l’elaborazione-espressione. Così si innesca un ciclo in cui l’investimento psichico è convogliato verso il dispegamento del desiderio, in una qualche misura an-oggettuale, e la soddisfazione di tale investimento deriva dai consigli di beni sempre potenzialmente migliori di quello inizialmente ricercato, ripiegando così l’atto desiderante su se stesso. Ovviamente la continua dilazione dell’acquisto non costituisce un’effettiva perdita in termini economici: la costante connessione dell’utente produce un enorme flusso di dati che nutre gli algoritmi di ricerca e le loro aziende proprietarie, portando a un profitto finale.
Rifacendosi alla actor network theory di Latour, l’autrice della ricerca suggerisce la possibilità che queste condizioni sanciscano un’effettiva cessione di agentività da parte dell’utente in favore del software, che assumerebbe dunque parte dell’attività psichica dell’attore umano e, in un ciclo, ne informerebbe la catena desiderante secondo i suoi criteri operativi.
Abbiamo scoperto dunque che la ri-distribuzione del desiderio fra agenti umani e non-umani risulta in una minore tendenza ad attualizzare le intenzioni di consumo nella realtà materiale. […] Il coinvolgimento con software che aiutano il consumatore a sviluppare le proprie decisioni crea, come risultato, un maggiore coinvolgimento con la tecnologia che con i beni desiderati.
La tesi, per quanto affascinante, è in definitiva piuttosto discutibile (benché si inserisca perfettamente nel milieu filosofico del realismo speculativo o della OOO) tuttavia, l’analisi esposta – derivata, e questo è fondamentale, non da speculazioni teoretiche ma da interviste, osservazioni e questionari – indica un elemento centrale di questo “desiderio digitale” ossia la sua relativa indipendenza da un oggetto (tanto in senso economico quanto psicoanalitico, posto che esista una differenza), la sua auto-affettività, e la sua condizione liminale fra virtualità e attualità. A conferma dei risultati dello studio citato, Niegel Thrift, geografo e studioso di teoria critica, sostiene che ormai i beni non sono più oggetti discreti che consumiamo – sono, piuttosto, puntelli di un processo il cui fine è la (ri)produzione del processo stesso. La tendenza sarebbe quella di un riorientamento del plusvalore prodotto nel processo verso l’inventività: “mercificare lo slancio di volontà per produrre un migliore ‘potere inventivo’”. Così, produzione, consumo e distribuzione collassano nella pura circolazione, in ciò che Thrift definisce “infrastruttura espressiva”. (N. Thrift, The Insubstantial Pageant: Producing an Untoward Land). In questo senso gli “oggetti” d’investimento psichico si situano in una soglia d’indistinzione fra memoria e proiezione – un’indistinzione esacerbata dalle dinamiche di incitamento libidico algoritmico. Ciò che avviene è in sostanza una potenzialmente infinita ricontrattazione fra (s)oggetto e piattaforma, in un ciclo in cui modalità desideranti umane e modelli induttivi-predittivi algoritmici si approssimano a un punto di totale indistinzione. Per parafrasare il CEO di Netflix: l’unico ostacolo è il sonno.
La natura proiettivo-mnestica del desiderio digitale, e la sua sostanziale indipendenza da un oggetto concreto, ricordano con estrema precisione la definizione freudiana della pulsioni inconsce – pulsioni contrapposte alle pulsioni dell’Io proprio perché svincolate da una dimensione oggettuale. Per Freud queste pulsioni non conoscono né oggetto né finalità; sono sempre parziali e la loro unica fonte di “appagamento” risiede nell’investimento degli oggetti “fantasmatici” – oggetti investiti dalle proiezioni inconsce del soggetto, che si pongono in netto contrasto con gli oggetti dell’Io poiché non “filtrati” dal principio di realtà. Il desiderio, tramite le pulsioni, non è mai in rapporto a un oggetto circoscritto, ma solo alle sue tracce mnestiche. Ne L’interpretazione dei sogni Freud scrive:
[L]’immagine mnestica [di una percezione] rimane d'ora in poi associata alla traccia mnestica dell'eccitamento dovuto al bisogno. Appena questo bisogno ricompare una seconda volta, si avrà, grazie al collegamento stabilito, un moto psichico che tende a reinvestire l'immagine mnestica corrispondente a quella percezione, e riprovocare la percezione stessa; dunque, in fondo, a ricostruire la situazione del primo soddisfacimento. E' un moto di questo tipo che chiamiamo desiderio; la ricomparsa della percezione è l'appagamento del desiderio.
E come glossa Dumoulié in Desiderio. Storia e analisi di un concetto:
In definitiva l’appagamento del desiderio non rappresenta il possesso di un oggetto reale, bensì la riproduzione allucinatoria di una percezione la cui immagine mnestica viene reinvestita.

Significativamente è proprio a partire da un testo freudiano - Al di là del principio di piacere - che Parisi e altri studiosi sviluppano le proprie teorie circa la relazione che intercorre fra soggetto ed ecologia mediatica. Nel testo Freud affronta la distinzione fra pulsioni organiche e inorganiche esaminando un’ipotetica cellula, la cui membrana è il luogo di mediazione fra interno ed esterno. Tuttavia, la vita organica diventa possibile, in questa descrizione, proprio grazie a una barriera-membrana inorganica da cui è, in definitiva, indistinguibile; anzi, sembra proprio che sia questa zona di indistinzione liminale ad organizzare la struttura dell’“interno”. A partire da questa considerazione che permette di articolare il rapporto di indistinzione che lega la nostra psiche e i nostri media, numerosi teorici abbandonano il quasi obbligato percorso della psicanalisi post-freudiana (Klein-Lacan) per recuperare le speculazioni di altri analisti, fra cui in particolare Didier Anzieu con la sua teoria dell’Io-pelle, in cui, in una qualche misura, le supposte “profondità” inconsce della psiche vengono “superficializzate” sulla pelle, primo luogo d’incontro e indistinzione fra pulsioni interne e pressioni esterne.
Il recupero di questa seminale nozione freudiana e di una serie di scritti di autori psicanalitici “non canonici” non è un semplice filologismo, ma è fondamentale per la formulazione di ciò che diversi autori, e in particolare Patricia Ticineto, Katherine Hayles e Niegel Thrift definiscono “non-conscio” o “inconscio tecnologico”. Benché le ricerche di queste autrici e autori divergano sotto molti aspetti, originano tutte da un assunto comune: l’inconscio è influenzato e modellato dall’ambiente tecnologico in cui l’essere umano è inserito. Dunque, se la dimensione socioculturale è fondante per lo sviluppo dell’identità psichica, lo sono allo stesso modo le tecnologie in cui questa dimensione nasce e attraverso cui viene articolata. Hayles nel suo saggio Trauma of Code scrive:
L'inconscio ha una dimensione storica, che si modifica in relazione all’ambiente artefattuale con cui interagisce.
Bisogna dunque
pensare alla cognizione come qualcosa che, lungi dall’essere limitata alla neocorteccia, ha luogo lungo l’intero corpo e si estende al di là delle barriere corporee nell’ambiente.
Secondo questa lettura è fondamentale operare una distinzione fra pensiero e cognizione: quest’ultima infatti permetterebbe di problematizzare “la barriera che separa la riflessione auto-cosciente e i processi inconsci”.
Se [la cognizione] viene considera nel contesto di un sistema integrato che include, per esempio, il sistema limbico e le funzioni motorie ad esso associate è ragionevole supporre che, così come le reazioni motorie si modificano in relazione a un ambiente tecnologicamente modificato, queste modifiche si riverbereranno nell’intero sistema cognitivo.
Queste tesi vengono riprese nel corso dell’intera opera di Parisi in particolare nel suo saggio Technoecologies of Sensation in cui viene minuziosamente sviluppata l’interrelazione fra reazioni somatiche e reazioni psichiche in risposta all’enorme quantità di micro-stimoli fornita dall’ecosistema digitale. Facendo riferimento agli studi sulla neurobiologia degli affetti di Antonio Damasio, che dimostrano un legame chimico e neurologico fra le attività del lobo frontale e del sistema limbico, Parisi reitera la tesi secondo cui le nostre capacità cognitive dipendano dalle stimolazioni emotive, a loro volta connesse a una serie di reazioni fisiche. Le reazioni emotive sono insomma “originarie”, le sensazioni coscienti sono invece un loro successivo sottoprodotto. Nel panorama digitale, il comportamento umano è sempre più immerso in un flusso incessante di dati e integrato all’inconscio tecnologico attraverso “risposte somatiche, feedback tattili, interazioni gestuali e un'ampia varietà di altre attività cognitive dipendenti dall’abitudine e dalla ripetizione e dunque collocate al di sotto della soglia di percezione cosciente” (Hayles, Trauma of Code. Corsivo mio) – in questo modo emerge una “sensibilità viscerale” che
registra immediatamente l’eccitazione prima che questa sia processata non solo dal cervello, ma anche dagli organi esterocettivi. Questa sensibilità interna tuttavia non è propria di un’interiorità strutturata (per esempio un Io). Tale profonda sensibilità piuttosto è propria dei ripiegamenti involuzionari della materia: una proto-sensazione che precede ed eccede l’organizzazione delle informazioni sensori nei canali neurosensoriali. (L. Parisi, Technoecologies of Sensation).
Nella sua esposizione Parisi sviluppa il concetto di involuzione macchinica per rendere conto delle nuove tecnologie digitali-mediali “né in termini di forma (medium tecnico), né di contenuto (il codice, il significante), ma come tecno-ecologie della sensazione che intersecano le capacità sensoriali energetiche, cognitive e affettive”.
Queste complesse formulazioni teoriche sembrano confermare, e garantire spessore speculativo, a quanto lo studio Redistributed consumer desire osservava su un piano empirico: esiste da un lato una sorta di “smaterializzazione” dell’oggetto del desiderio, e, contemporaneamente una “digitalizzazione” del desiderio del soggetto. Dal momento che i beni si trovano in una situazione liminale di quasi-materialità – esistono insomma in bilico fra immaginazione, memoria e proiezione – vengono svincolati dalle contingenze empiriche che costituiscono gli argini pulsionali del principio di realtà. Al di fuori del principio di realtà, le pulsioni operano circolarmente su se stesse, seguendo le tracce mnestiche di un oggetto e non un oggetto concreto. Queste tracce mnestiche corrispondono alla serie di stimolazioni psicofisiche a cui siamo costantemente sottoposti – non articolabili proprio perché al di sotto della soglia di coscienza: l’unico modo per “dare forma” a queste tracce mnestiche è affidandosi ai suggerimenti algoritmici, che, come evidenzia lo studio, pongono alcuni “puntelli” per lo sviluppo di questo desiderio an-oggettuale. Tuttavia, dal momento che la logica di elaborazione algoritmica è induttiva ciò che viene offerto non è un oggetto preciso, ma un “sistema” di oggetti sempre più perfezionabili attraverso cui il nostro desiderio si (dis)articola, in un processo il cui fine è il processo stesso.
In questo modo si instaura un ciclo in cui, se forse è eccessivo sostenere che avvenga una cessione di agentività, il funzionamento dell’inconscio personale e dell’“inconscio tecnologico” (ossia il sostrato tecnico a cui “cediamo” contenuti psichici e che ne sostiene l’elaborazione) si ibridano e si influenzano vicendevolmente in un continuum che porta alla progressiva elisione delle barrire che separano organico e inorganico. E questa continuità viene inevitabilmente intensificata dall’esponenziale esposizione a stimolazioni digitali, le “reazioni emotive preconsce” descritte da Parisi. In questo modo avviene una sorta di ricodificazione “ontologica” – non ci sono due piani di realtà distinti, gli stimoli prodotti ed elaborati creano effetti reali, indipendentemente dalla loro origine. Non è più una questione di realtà e finzione (ammesso che mai lo sia stata) – il continuum psichico inconscio personale-inconscio tecnologico equivale a una profonda ricalibratura percettiva.
I media non sono ‘apparati significanti’ – una rete di trasmettitori e ricevitori che ‘mediano’ input estrinseci. Piuttosto i media sono circuiti d’intensità anorganici, che non traducono un ‘messaggio’ ma trasformano ogni input. (M. Fisher, Flatline Constructs).
Non c’è, fisiologicamente e psicologicamente, alcuna differenza fra una stimolazione reale e una simulata. Numerosi esperimenti condotti attraverso la realtà virtuale hanno dimostrato come sia possibile, grazie all’immersione in scenari appositamente progettati, curare fobie “minori” come l’aracnofobia. Non è più una questione di realtà – ciò che conta è la comunicazione.
Questa circuiteria inoltre non si limita a ricodificare gli input sensoriali, ma ricalibra la stessa articolazione-distinzione fra Io e Rete e, in virtù della sua operatività che collassa forma e contenuto, ricodifica ogni elemento comunicativo in pura circolazione che opera secondo criteri incrementalmente preconsci, in un “ambiente artificiale caratterizzato dalla crescita esponenziale di dispositivi cognitivi non-consci” (Parisi, Critical Computation). Questo ecosistema mediale si astrae dalle necessità della rappresentazione e della significazione, per entrare nel dominio di ciò che Marc Boumeester in Medium Affect Desire: Hybridising Real Virtual and the Actualised through Affective Medium Ecology definisce “segno asignificante”, il cui ambiente di proliferazione è tendenzialmente
un ambiente sovraccarico di informazioni (visive), e che [contiene] un’enorme varietà di narrative (simboliche), di diversi sistemi semiotici e semantici (visuali) e numerosi livelli denotativi e connotativi.
In questo ambiente
non esiste alcun valore rappresentazionale […] Il segno asignificante opera a un livello preconscio. (Corsivo mio).
Il che implica che la supposta articolazione dell’Io mediante valori Simbolici inizi a incrinarsi e a venire reintegrata secondo operatività circolari e a-significanti, an-oggettuali che non solo ricodificano desiderio e inconscio ma anche l’identità personale.

Il collasso di forma e contenuto crea ciò che Benjamin Bratton definisce ricorsione fra utente e interfaccia. L’Io, quantificato come User (o Utente) e le sue tracce digitali sono il medium di una costante riprogrammazione dell’Utente stesso. La ricorsione o circolarità è data dal fatto che nello Stack (una complessa mega-architettura che implica tutti i livelli di organizzazione tecnologica globale) l’identificazione e la quantificazione o misurazione dell’Utente è operata su “Utenti che già organizzano se stessi secondo i criteri degli strumenti utilizzati per effettuare la misurazione”. (B. Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty). O, come scrive Bifo in Futurabilità
Perché ci possa essere effettiva comunicazione, l’agente dell’enunciazione deve usare un linguaggio che sia comprensibile dalla macchina. Una volta che l’agente dell’enunciazione ha accettato il formato che rende possibile l’interazione, l’interazione può evolversi e la macchina si può adattare all’organismo vivente – fin quando l’organismo vivente non si è a sua volta adattato alla macchina.
Certo, l’Io non è (ancora) completamente livellabile sulla sua posizione di utente: la mia esistenza di utente è un costrutto digitale che non può rispecchiare appieno la mia personalità. Eppure, ogniqualvolta ci connettiamo, passiamo da un oggetto suggerito a un altro, lo facciamo secondo criteri predittivi algoritmici, secondo la nostra immagine immagazzinata e nutrita dalla piattaforma – insomma incorporiamo bit dell’Utente sviluppando le sue preferenze. Ne introiettiamo costantemente le componenti: è davvero pensabile che sia così nettamente separabile dal nostro Io? In questa dimensione si concretizza (attualizza) la già menzionata diagnosi di Jameson dello sfaldamento dell’Io i cui confini privati diventano indistinguibili dagli snodi della rete. Questa progressiva indistinzione porta la critica dei media Wendy Hui Kyong Chun a ridefinire l’Io come “YOU”, una nuova figura in cui le tracce digitali dell’Io-Utente sono collassate in uno snodo della rete, sancendo così l’erosione della differenza fra personale e pubblico. Così non si tratterebbe di un Io “alienato” nella tecnologia (in una sorta di sussunzione formale), ma di un Io che integra sia a livello fisiologico che affettivo-rappresentativo le funzioni della struttura attraverso cui si (dis)articola (sussunzione reale). Anche l’auto-rappresentazione – che sia narrativa o visuale – ricade nelle condizioni di smaterializzazione o perfezionabilità asintotica descritte in relazione al desiderio del consumatore: il (s)oggetto si ritrova in una situazione liminale fra immaginazione (virtualità) e rappresentazione (attualità) – fra la propria immagine ideale e la creazione, grazie al digitale, di quella immagine - ed è costantemente suscettibile di miglioramento in una traiettoria di realizzazione fantasmatica della rappresentazione perfetta.
Quanti selfie eliminiamo prima di postare quello con la luce e l’angolazione perfetta? Quante volte ritocchiamo una foto prima di postarla? Quante volte modifichiamo i nostri post in base al feedback ottenuto da quelli precedenti? Ma nulla, come nell’inconscio, viene realmente negato: anche gli elementi rimossi o modificati sono contrassegnati da una scia di metadati che si inserisce nel flusso di elaborazione algoritmica e alimenta la raccolta quantitativa di dati digitalizzati che costituisce il tessuto dell’Utente. Nell’erosione dei confini fra personale e relazionale, (s)oggettivo e an-oggettivo, si riverbera la condizione upgradata del narcisismo menzionata in apertura: l’impossibilità di distinguere il soggetto dalla sua rappresentazione.
L’insieme di reazioni preconsce innescate da questi meccanismi, portano Wendy Hui Kyong Chun a descrivere la relazione fra YOU e social media in termini di abitudine – abitudini non solo emotive-cognitive ma anche micro-motorie o micro-percettive. È per esempio il caso dei social che per articolare la propria operatività sfruttano il meccanismo di rilascio dopaminico innescato dal feedback legato ai contenuti o al senso di aspettativa che accompagna la comparsa di una nuova notifica. Questa relazione “istintiva” ricade sotto la soglia di coscienza e opera, secondo Chun, come il “non-conscio produttivo dei social media”. (W. H. K. Chun, Updating to Remain the Same: Habitual Media). È il medesimo meccanismo che Fisher definisce come dipendenza o assuefazione:
La relazione fra l’organismo umano e l’ambiente tecnologico viene intesa non più in termini di estensioni organiche, ma come circuiti-di-dipendenza […] l’assuefazione implica sempre un divenire-inorganico dal momento che implica l’inserimento dell’organismo in circuiti retroattivi extra-organici.
La dipendenza […] viene trasferita nelle macchine tecniche, come componente produttiva di un desiderio artificiale (=dipendenza macchinica). (M. Fisher, Flatline Constructs).
La tesi della connessione Io-Rete e della retroazione fra i due inconsci, trova, oltre che nelle analisi neurobiologiche e della teoria degli affetti, una conferma nelle teorie della psicoanalista americana Sue Grand, che, a partire dalle formulazioni kleiniane delle dinamiche di introiezione ed espulsione degli oggetti parziali, ipotizza la possibilità che l’Io sviluppi – in particolare in rapporto a esperienze traumatiche, che come già Freud notava, sono sovraccarichi energetici non completamente decodificabili dall’apparato psichico – una “forma non-fisica”, in una sostanziale ricusazione dell’equazione fra esperienza individuale e limitazioni corporee.
Forse, le sensazioni dell’‘Io’ possono contrarsi ed espandersi fino ad includere o escludere il corpo, in modo da non essere derivate esclusivamente dagli stati corporei. Forse possediamo una sorta di Io psichico non-umano sviluppato in relazione alla ‘cultura’ non-umana.
Se la psiche si forma attraverso la relazione con gli altri umani, si forma anche in relazione al mondo non umano. È possibile che noi tutti possediamo un originario Io-Cosa. (Sue Grand, Unsexed and Ungendered Bodies: The Violated Self)
Le tre complesse macro-tematiche che emergono nella letteratura specialistica menzionata (la dipendenza dell’apparato psichico dall’ecosistema tecnologico e la conseguente indistinzione fra psiche e techne; l’elisione dei confini fra organico e inorganico e l’an-oggettività attuale/virtuale del desiderio digitale) coincidono con estrema precisione alle caratteristiche di una nuova forma di sentire che Mario Perniola definisce “sessualità neutra”. Nel suo Il sex appeal dell’inorganico, Perniola intravvede nella modernità le tracce germinali di una nuova forma di percezione in grado di dimostrare la contingenza e infine di decostruire una serie di immagini del pensiero che fanno dell’uomo il soggetto privilegiato dell’esperienza e radicano la percezione nella dimensione biologica. La sempre maggiore interazione con il virtuale ricalibra radicalmente le dinamiche psichiche e desideranti del soggetto, dispiegando uno scenario in cui l’eccitazione e l’investimento libidico si collegano a una sempre più radicale astrazione. La sessualità neutra sorgerebbe dal desiderio dell’uomo di “far coincidere la più alta forma di virtualità con la più alta forma di attualità (come nella moneta)”. La sintesi virtuale/attuale operata dai media delinea la via d’accesso a una dimensione in cui la sensazione si cristallizza in un’esperienza senza scopo. La virtualità, scrive Perniola, garantisce “l’accesso a una nuova dimensione ontologica”. Qui la modalità di esperienza mette in comunicazione l’Io e le sue “protesi” confondendo i loro confini e rendendo il soggetto “una cosa che prova” – esso stesso “protesi” di un desiderio che lo eccede. In quest’ottica “la cosa e la sensazione devono essere considerate in sé e non in funzione di un soggetto senziente” (corsivo mio). La sessualità neutra inoltre inserisce l’Io (cosa) in un flusso acefalo desessualizzato (e dunque svincolato dalle costrizioni biologiche e ricodificato secondo l’operatività cibernetica), indifferente alla funzionalità climatica del rilascio energetico (orgasmo e/o consunzione) – in una ciclicità non-finalistica che reitera solo se stessa e la propria propagazione.
La sessualità neutra crea una dipendenza infinita poiché si sottrae dai ritmi e dai cicli biologici. […] ci introduce a un movimento senza tempo e senza scopo […] che non richiede altro che la propria continuazione.
Nello scenario dell’ecosistema digitale l’Io (dis)integra le proprie percezioni in un circuito di immagini prive di referenza, di “protesi” che non segnano più la distinzione fra corpi, ma ne permettono al contrario la comunicazione, secondo criteri di “porosità” – un potenzialità d’accesso e integrazione infinita che indicizza l’emergenza di una vita intrinseca al non-organico. Non esiste insomma, secondo Perniola, una dicotomia ontologica, ma una nuova concrezione di diversi livelli che rende possibile l’accesso a nuove modalità del sentire, in grado di decostruire le limitazioni biologiche, psichiche e culturali che inibiscono la riorganizzazione dell’intera esperienza.
Nonostante la brevità – e forse la violenza – di questa sintesi, è evidente come le speculazioni di Perniola risuonino con quanto emerge da ricerche condotte in ambiti diversi e secondo metodologie diverse.
E questa convergenza è difficilmente imputabile al caso. Certo, il dato quantitativo non costituisce una prova, tuttavia testimonia di una diffusa sensazione della necessità di indagare le modifiche che, in maniera sempre più evidente, le tecnologie apportano al nostro modo di esperire e di pensare. E soprattutto della necessità di ripensare le categorie che informano la nostra concezione della psiche e del suo rapporto con l’ecosistema informatico. Senza dubbio le formulazioni menzionate restano – per ora – limitate in una dimensione speculativa che tuttavia non ne costituisce un limite. Lo scollamento fra la velocità delle trasformazioni tecnologiche e le capacità d’elaborazione umane rende impossibile una mappatura sincronica e scientificamente esatta – l’osservazione speculativa dunque, proprio per la sua plasticità resta per ora forse il modo più efficace per riflettere sui fenomeni nel momento stesso della loro emersione, soprattutto per rendere conto delle loro implicazioni sociali e politiche. E anzi, forse testimonia – in una ciclicità sintomaticamente cibernetica – del progressivo ri-orientamento della cognizione secondo modalità non-consce, e, al contempo, della convergenza fra pensiero ed emozione.
In questo senso, Parisi e Perniola in particolare, vedono in questo divenire-digitale del desiderio una serie di potenzialità emancipatorie. La decostruzione cibernetica della supposta naturalità dell’uomo, la liberazione dai modelli di organizzazione sociale esistenti, la definitiva frattura nella logica rappresentativa che organizza le opposizioni come coppie dicotomiche, minerebbero alla base la contingenza delle costruzioni e costrizioni discorsive che limitano l’autodeterminazione della soggettività, e in particolare delle soggettività oppresse, offrendo, grazie a questa nuova forma di sentire, una radicale possibilità di rivoluzione dell’esistente e di creazione di nuove e alleanze e modalità d’esistenza.
Questo scenario però è offuscato da un’ombra: le piattaforme che rendono possibili queste ibridazioni e riconfigurazioni sono in larga parte di proprietà delle grandi aziende tecnologiche e la loro operatività è di conseguenza informata da un ben preciso frame valoriale. L’“esternalizzazione” cognitivo-emozionale rischia di realizzare una ancor più profonda penetrazione dei meccanismi del capitale nella nostra vita quotidiana, portando a un nuovo livello di sofisticazione la già diagnosticata ascesa del Neurocapitalismo.
Se esiste un effettivo sostrato tecnico del nostro inconscio, il fatto che questo sostrato sia di proprietà del capitalismo tecnologico non può che portare a un ancora più profondo rapporto di dipendenza dai suoi mezzi, non solo per l’organizzazione delle nostre attività, ma per l’articolazione stessa della nostra esistenza psichica. Perniola ne è chiaramente consapevole: mantenendo intatto il contesto valoriale capitalistico ciò che la digitalizzazione ottiene non è una liberazione, o l’accesso alla dimensione della “cosa”: ciò a cui il capitale “aspira non è mai una vera cosa, ma solo un sottoprodotto parassitico dell’organico” (M. Perniola, Il sex appeal dell’inorganico). Più prosaicamente, la libertà insita nella convergenza biotecnologica è limitata dalla reiterazione degli stessi criteri valoriali che questa si propone di dissolvere, in un processo che Nick Land definisce sintesi inibita: l’innovazione del capitale rende possibile l’eliminazione delle costrizioni reazionarie della tradizione, ma, al contempo, mantiene inalterate alcune strutture “protettive” nucleari come l’identità, al fine di ricodificare i flussi liberati come mezzi di produzione del valore.
C’è in questo un parallelo evidente con il meccanismo operativo dell’ideologia identificato da Žižek e Fisher: questa riesce a perpetrarsi inalterata proprio perché viene riconosciuta come finzione – sono consapevole che questi non sono veri valori, dunque questa consapevolezza mi permette di continuare ad esservi agito, nella convinzione di conservare nel profondo qualcosa di inalienabile. Allo stesso modo, il mantenimento dell’opposizione dicotomica fra reale e digitale, verità e copia, permette la sussunzione dell’attività online che si ritiene ininfluente sulla nostra vera “essenza”.
Nell’economia relazionale del tecno-capitale, l’Io digitalizzato è insomma un valore su cui investire: la già menzionata possibilità di perfezionamento asintotico e le disfunzioni identificative che ne conseguono non possono che portare a un sempre maggiore investimento affettivo (e a un sempre maggior numero di ore spese davanti allo schermo) che da un lato crea una sempre più profonda incorporazione delle logiche operative dei social media, e dall’altro una sempre maggiore quantità di dati sull’Utente. In questo modo si giunge a consolidare sia il tessuto informatico secondo cui la piattaforma articola la nostra esistenza online, sia, ciclicamente, a un appiattimento su quell’immagine, così da realizzarne infine l’esistenza.
È proprio la distanza ipotetica che separa l’Io e il suo simulacro – che viene ritenuto dunque nulla più che segno – la condizione per la nascita di ciò che Klossowski definisce moneta vivente: un oggetto che, proprio in quanto “simulacro” cioè recettore delle proiezioni fantasmatiche, sugella la fusione fra economia e “voluttuosità” facendo dei corpi e dei soggetti (Utenti) un’unità scambiabile. E non è forse ciò che avviene, germinalmente, con la circolazione del costrutto Utente e la scia di dati che crea? Questa speculazione – già piuttosto presciente – nel contesto attuale, necessita in ogni caso di un upgrade: l’Io (YOU/User) non è solo unità scambiabile, ma anche appendice biotica di (ri)produzione e del valore informatizzato.
L’intersezione fra capitalismo e desiderio è stato un filo conduttore negli scritti di Mark Fisher, che, in Spettri della mia vita, vede nel “subconscio” digitalizzato di Inception una sorta di testimonianza della parassitazione della nostra vita psichica da parte del neuromarketing del capitale. In relazione al finale del film, liquidando ogni arabesco ontologico, Fisher evidenzia come – in un simile contesto - non ha alcuna importanza che Cobb stia ancora sognando o meno. La questione cruciale è un’altra: a chi appartiene quel sogno? Se le tecnologie mediali non solo costituiscono la dimensione “materiale” di articolazione del nostro inconscio-desiderio, ma ne incanalano lo sviluppo e ne informano il funzionamento forse dovremmo iniziare a porci una domanda simile.
A chi appartiene il nostro inconscio?
Pensiero
#3 Attenzione!
21-04-2021
08-06-2021